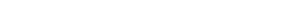Cinque appuntamenti con i principali protagonisti del jazz
Cinque appuntamenti con i principali protagonisti del jazz
di Giovanni Greto
Premessa. Il 92enne Compay Segundo con la sua orchestra, il 31 dicembre 1999 suonò e cantò al Palafenice, brindando con il pubblico al nuovo millennio. Non fu un concerto memorabile, ma, sull’onda del successo esploso grazie alla pellicola di Wim Wenders e in virtù di un’innata simpatia e di un vocione formatosi nel tempo fumando sigari e bevendo rum, il pubblico tornò a casa per lo meno soddisfatto di aver conosciuto un personaggio carismatico, d’altri tempi, sicuramente in via d’estinzione. Parecchi musicisti di quell’orchestra, dal cantante Hugo Garzòn ai due figli Salvador e Basilio Repilado, il cognome di Compay, si sono rivisti, a 12 anni di distanza, nel primo appuntamento della quinta edizione del ‘Venezia Jazz Festival’.
La formazione, composta da 10 elementi, ha eseguito professionalmente, ma senza nessun sussulto, un repertorio in gran parte tratto dal disco ‘Buena Vista Social Club’, inciso nel 1997, che dopo l’uscita del film nel 1999, avrebbe venduto 8 milioni di copie, e completato dai più visitati ballabili che ogni orchestra di tutti i continenti esegue negli alberghi, nei ristoranti o in qualsivoglia posto quando si festeggia l’arrivo dell’anno nuovo. Da ‘El Carretero’ a ‘Chan Chan’, i musicisti hanno entusiasmato un pubblico in gran parte poco avvezzo alla qualità della musica, semplicemente disposto a lasciarsi trascinare da una banale orecchiabilità. Come se non bastasse, a commentare coreograficamente alcuni pezzi, è intervenuta una coppia di ballerini italiani, in evidente difficoltà, indirizzando ancor più lo spettacolo verso i territori del Kitsch.
Il secondo ed ultimo appuntamento dedicato alla musica latina, piatto forte del cartellone, ha riservato un’ennesima, anche se prevedibile, delusione. Sorridente, senza chili di troppo, a 70 anni Gilberto Gil continua a calpestare il palcoscenico – la data della Fenice era l’ultima della tournee europea – suonando la chitarra, cantando, tenendo una specie di lezione-concerto, senza dubbio utile a quella parte di pubblico non sufficientemente acculturata sulla storia della musica popolare brasiliana. Ma se le mani fanno ancora il loro dovere, le corde vocali appaiono indebolite. Nonostante una scelta strumentale poco invadente, anche le corde e le percussioni, che danno il nome al concerto, sembrano troppo potenti per la sua attuale forza canora. Peccato, perché il repertorio, tolte ‘Up from the skies’ di Jimi Hendrix e la melodia messicana ‘Tres palabras’ di Javier Solis, è costruito con intelligenza. C’è l’omaggio al padre della bossa nova, Antonio Carlos Jobim, in ‘Outra Vez’, quello alla terra madre e ad uno dei suoi più antichi cantori, Dorival Caymmi, in ‘Saudade da Bahia’, l’accenno al folclore del sertào, il deserto brasiliano, in ‘Lamento sertanejo’ di Dominguinhos e ai ritmi nordestini di Luiz Gonzaga in ‘Juazeiros’. Non può mancare una canzone di Caetano Veloso, scelta tra le meno conosciute, ‘Panis et circensis’, a suggellare un’amicizia che continua nel tempo. E poi, dal suo canzoniere, titoli come ‘Domingo no parque’, ‘Xangò’, una delle divinità del Candomblè, la religione che ebbe origine con l’arrivo degli schiavi dall’Africa, ‘Expresso 2222’, ‘Viramundo’. Tutte canzoni che una ventina d’anni fa avrebbero fatto saltare dalle seggiole anche quelle signore presenzialiste, il cui scopo di andare a teatro è solo quello di farsi notare. Si è capito poi quanto perfino i brasiliani presenti fossero rimasti delusi, poiché non hanno partecipato con la consueta bravura canora e ritmica che li contraddistingue, assieme alla carica emotiva, all’invito del leader di intervenire in alcuni brani. Il pezzo più bello, eseguito in solitudine da Gil nella penombra, per sola voce e ticchettii percussivi sulla cassa della chitarra, è stato ‘Nào ter medo da morte’, un coraggioso faccia a faccia con la morte. Attenti e precisi, ma senza picchi negli assolo, sia Morelenbaum al violoncello elettrico, che Krassik al violino e il figlio Bem, il cui compito sembrava più quello di rafforzare il fraseggio del padre. Buona la prova di Gustavo Di Dalva, da 16 anni con Gil, che ha saputo padroneggiare un nutrito set percussivo ben selezionato, con l’eccezione, forse, del cajon, apparso fuori contesto. Sorprendenti, due giganteschi Caxixi, costruiti da un artigiano di Bahia, che si sono inseriti nelle trame degli archi con sicurezza e personalità.
Immersi nella quiete del giardino della Collezione Guggenheim, disturbata qua e là dal volteggiare minaccioso di un elicottero dotato di laser, forse alla ricerca di qualcosa fra i tetti di Venezia, il pianista/compositore Cesare Picco ha dato un saggio della propria abilità tecnica in una serie di brani, 8 per la precisione in 83 minuti. Dal ‘Preludio n. 1 in do maggiore’, con cui si apre il primo libro del ‘Clavicembalo ben temperato’ di J. S. Bach, eseguito con i polpastrelli a sfiorare i tasti, Picco ha iniziato ad improvvisare, rivelando un temperamento romantico inserito in un filone minimalista, vale a dire melodie facilmente cantabili, ripetute per creare una specie di trance, o quanto meno di rilassamento. Ci sono stati anche brani nei quali l’artista si è alzato in piedi per strisciare le corde collegate ai tasti creando una certa suspense, catturando una platea curiosa di ascoltare come il brano si sarebbe sviluppato. E’ stato eseguito ‘Piano calling’, che dà il titolo all’ultimo disco, nel quale i pezzi sono anche indicati con la scrittura dell’alfabeto Morse. Una musica sia delicata, che vigorosa, attraverso l’utilizzo del pedale, e che diventa più o meno godibile a seconda dello stato d’animo di chi la ascolta. Applausi convinti hanno reso felice il pianista, lieto di concedere un breve bis, che ha ricordato l’austerità di certe melodie beethoveniane.
L’ultimo appuntamento di richiamo della quinta edizione del ‘Venezia Jazz Festival’ è anche l’unico in cui si ascolta Jazz. Apre la serata il quartetto del pianista norvegese Tord Gustavsen, quattro Cd incisi per l’etichetta ECM, in trio, tranne il recente ‘The Well’, dove si aggiunge il sassofonista Tore Brunborg. Una sonorità calda e corposa la sua, che ben si inserisce a commentare le composizioni del leader, inizialmente cupe, ma che poi gradatamente si aprono all’improvvisazione collettiva. Mentre suona, Gustavsen si muove con tutto il corpo ma, per fortuna, non emette quelle sonorità vocali fastidiose, di cui si fece capostipite Keith Jarrett, influenzando, purtroppo, molti musicisti, non solo pianisti. Il repertorio proposto spaziava da composizioni già esistenti a novità per una probabile nuova incisione. Nelle brevi presentazioni, il pianista ha spiegato che spesso il gruppo suona nelle chiese, confermando un qualche cosa di spirituale, di cui la sua musica si fa portatrice. A volte il quartetto ricorda quello europeo di Jarrett, ma Brunborg è preferibile a Garbarek, dal suono nasale più accentuato. La ritmica, assai attenta, non è mai invasiva: i due musicisti mettono in pratica con intelligenza ciò che il leader chiede loro. E così le dinamiche sonore sono perfette. I volumi crescono e si diradano, come una tavolozza di colori, ora intensi, ora tenui. Eilertsen si distingue per degli assolo ben costruiti, dai quali si espande un suono profondo e morbido nello stesso tempo. Spesso contrabbasso e batteria tacciono, quasi a raccogliere le idee per poi ripartire colmi di nuova linfa creativa.
Giusto il tempo necessario per togliere il drum set e riposizionare il pianoforte, ed ecco salire sul palco la trentatreenne pianista giapponese Uehara Hiromi, la quale dal 2003 ha iniziato ad incidere una serie di dischi, apprezzati sia dai musicisti che dalla critica. Fisicamente minuta, dal vivo Hiromi è comunque una forza della natura, anche se il suo pianismo è spesso troppo pieno, il fraseggio la prende per mano, col risultato di voler dimostrare quanto brava essa sia. Il pubblico comunque si appassiona e le tributa applausi ed acclamazioni durante un intenso set di 75 minuti, iniziato da una pirotecnica, vertiginosa versione di ‘I got rhythm’ di George Gershwin, il compositore più amato dall’artista, secondo quanto da lei stessa affermato alla fine dell’esecuzione. Hiromi, che non disdegna di percuotere il legno dello strumento, passa con disinvoltura da uno stile che ricorda Monk, ad uno legato all’era dello Swing, o, ancora più a ritroso, dello Stride piano. Tutto questo con grande bravura, anche se non c’è ancora un tocco per cui, di primo acchito, l’ascoltatore si rende conto subito di chi stia suonando. Tra i brani in scaletta, ‘Sicilian Blue’, contenuto anche nell’ultimo disco ‘Place to be’, una melodia che le è venuta di getto visitando la Sicilia, in modo molto naturale, probabilmente “ a causa di un cielo così azzurro, di un oceano blu e di incantevoli strade”.